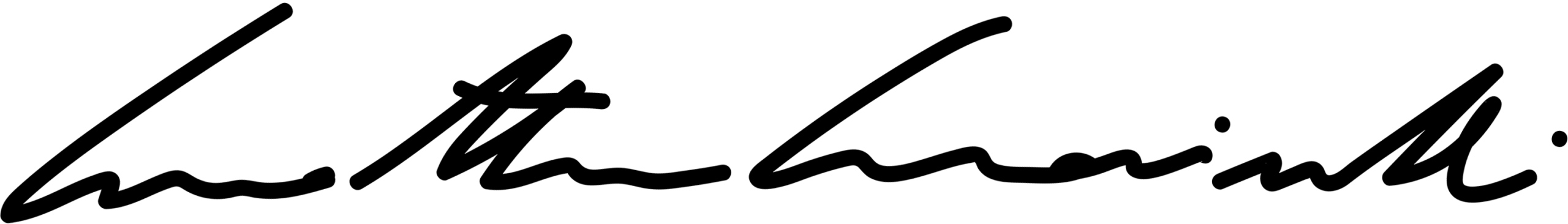Nell’ombra lunga e contorta di una città il cui nome stesso sembrava essersi perso nel fumo degli opifici e nel frastuono delle ambizioni umane, viveva un uomo il cui destino, sebbene inizialmente modellato dalle mani callose della semplicità, sarebbe divenuto un emblema di quelle cadute morali che affliggono gli spiriti illusi dal luccichio effimero del progresso. Corrado, così era chiamato, abitava in un vicolo dove i muri, impregnati dell’umidità di secoli, sussurravano storie di generazioni dimenticate, e dove la luce del sole, filtrando attraverso le imposte screpolate, disegnava geroglifici di polvere che solo un animo contemplativo avrebbe potuto decifrare. La sua esistenza, fino ai trentacinque anni, era stata un idillio di rinunce nobili: sveglia all’alba, quando le strade ancora dormivano avvolte nella nebbia perlacea delle cloache; passeggiate solitarie lungo gli argini del fiume, dove le ninfee galleggiavano come monete d’argento gettate da un re penitente; serate trascorse nella piccola biblioteca civica, tra volumi il cui odore di muffa era più eloquente delle parole stampate. Non possedeva nulla, se non una giacca di tweed logora ai gomiti e una collezione di sassolini levigati dall’acqua, ciascuno testimone muto di un’epifania silenziosa.
La sua filosofia, coltivata come un giardino segreto in un deserto di cemento, si nutriva di un’asserzione semplice e rivoluzionaria: che la vera grandezza risiedesse nell’arte del non-desiderio. Finché, in un giorno maledetto il cui calore faceva sudare anche le statue dei santi, l’amico Marco, già allora un essere ibrido, metà uomo e metà prospetto finanziario, lo trascinò in un salotto dove i tappeti persiani erano così folti da far affondare i talloni come in paludi di velluto, e dove i bicchieri di cristallo di Boemia tintinnavano in una sinfonia di autocelebrazione.
“Guarda”, sibilò Marco, indicando un orologio da taschino il cui quadrante era tempestato di diamanti che brillavano come occhi di demoni addormentati, “questo non segna il tempo, Corrado, lo possiede.” E in quel momento, come un chicco di grandine nel cuore di una perla, si insinuò nel petto del nostro eroe il primo germe di corruzione. Che cos’era, in fondo, la sua collezione di sassi rispetto a queste pietre che imprigionavano la luce? Le sue passeggiate solitarie, non erano forse la scusa di chi non osa competere? E quella notte, mentre tornava a casa in un taxi la cui tappezzeria odorava di ambizione repressa, Corrado iniziò a odiare il silenzio.
La metamorfosi che seguì fu lenta, impercettibile e terribile come lo sbocciare di un fungo velenoso. Prima furono gli accessori: una cravatta di seta così sottile da sembrare tagliata dalle ali di un cherubino, acquistata a credito; poi un orologio svizzero il cui ticchettio metallico sostituì il ritmo cardiaco come metronomo esistenziale. La sua casa, un tempo santuario di libri e tazze screpolate, si riempì di oggetti che urlavano il loro prezzo: statuette Art Déco dagli sguardi vacui, tappeti anatolici che reclamavano attenzione con motivi geometrici aggressivi, un divano Chesterfield la cui pelle rossa sembrava scuoiata a qualche animale mitologico. Ogni acquisto era una stilettata alla sua vecchia identità, eppure Corrado, inebriato dall’odore di cuoio nuovo e dal fruscio delle banconote, scambiava il sanguinamento per una sorta di purificazione.
Nel lavoro, un impiego da semplice contabile in una ditta di spedizioni marittime, iniziò a vedere non più un mezzo per sostentarsi, ma una palestra per affilare artigli che non sapeva di possedere. Arrivava per primo, partiva per ultimo, si offriva per compiti che altri rifiutavano, accumulando favori come un avaro accumula monete. La sua promozione a direttore finanziario (titolo che fece stampare su biglietti da visita con caratteri così rilievo da poter essere letti al buio) coincise con l’acquisto di un’automobile la cui carrozzeria luccicava come un coltello appena affilato.
Fu in questo periodo che iniziò a classificare gli esseri umani in categorie mutuate da manuali di economia: “attività” o “passività”, “investimenti” o “costi irrecuperabili”. La moglie del droghiere, che un tempo gli regalava biscotti al burro avvolti in carta oleata, divenne una “perdita secca”; il vecchio bibliotecario che gli aveva insegnato ad amare i poeti maledetti fu retrocesso a “capitale obsoleto”. Persino i suoi sogni, un tempo popolati di paesaggi bucolici, si trasformarono in diagrammi di flusso dove figure umane danzavano legate da frecce che puntavano tutte verso l’alto, verso un “successo” indefinito ma assoluto.
Ma come Icaro anche Corrado aveva un tallone d’argilla: più saliva, più il mondo sottostante perdeva colore.
I pranzi in ristoranti stellati, dove il cibo era disposto in geometrie astratte che ne negavano la natura terrena, lo lasciavano affamato di quella zuppa di lenticchie che la madre preparava nelle sere di pioggia. Le conversazioni sul mercato azionario, condotte in un gergo cifrato che trasformava le emozioni in decimali, gli facevano rimpiangere le discussioni sul miglior modo per innestare un melo. Una notte, dopo un cocktail party dove aveva riso a comando per battute che non lo sfioravano, si ritrovò a piangere davanti allo specchio del bagno, le lacrime che rigavano un viso reso irriconoscibile dal troppo sole artificiale.
Il culmine della parabola, perché di parabola si tratta con la sua inevitabile discesa, giunse con l’acquisto di una villa neoclassica le cui colonne scanalate sembravano ossa di giganti sepolti. Arredata da un interior designer milanese che parlava per metafore architettoniche (“Questo salone deve essere un sonetto petrarchesco in marmo travertino!“), la casa era un museo di freddezze: pavimenti così lucidi da riflettere il vuoto dei soffitti a volta, caminetti che non avevano mai conosciuto un vero fuoco, librerie contenenti volumi rilegati in pelle ma privi di pagine, mere scatole dorate per ingannare visitatori altrettanto vuoti.
Fu qui, in una notte di novembre dove la luna sembrava un occhio spento, che Corrado fece l’inventario della sua vita. I conti in banca, gonfiati come cadaveri annegati; i vestiti sartoriali, che lo stringevano come una seconda pelle aliena; le conoscenze influenti, nomi senza volti in un Rolodex d’avorio: tutto si rivelò per ciò che era, un castello di carte costruito sopra l’abisso. Tentò di leggere un libro, ma le parole scivolavano via come insetti impauriti; provò a camminare nel suo giardino zen, ma i sassi disposti con precisione millimetrica gli ricordarono i suoi ex-voti al denaro.
La vera punizione, però, giunse all’alba. Mentre osservava dalla finestra termica un barbone che dormiva beatamente su una panchina, avvolto in giornali come in un mantello regale, Corrado realizzò con un brivido che quell’uomo, seppur privo di tutto, possedeva esattamente ciò che lui aveva perduto: la capacità di godere di un raggio di sole, il profumo del pane fresco, il lusso supremo di non dover dimostrare nulla a nessuno. In quel momento, il suo cuore divenne un cencio, e il pianto che ne seguì non era di tristezza, ma di vergogna, vergogna per essersi lasciato ingannare dal più banale degli inganni, quello che scambia l’avere per l’essere.
Negli anni che seguirono, anni che trascorse come un fantasma nei corridoi del potere, Corrado divenne un ammonimento vivente. I colleghi che lo invidiavano non sapevano che il suo ufficio angolare era una cella, che i suoi abiti di cashmere erano sudari, che ogni stretta di mano nascondeva una preghiera disperata di riconoscimento autentico. Morì giovane, stroncato non da un male fisico, ma da quella malinconia perenne che nasce quando l’anima, ridotta a contabile delle proprie mancanze, smette di credere nella resurrezione.
La sua tomba, un mausoleo di granito nero che aveva commissionato in un accesso di autocelebrazione postuma, divenne presto meta di gite scolastiche. “Vedete”, dicevano i professori indicando le lapidi sfarzose, “questo è ciò che accade quando si scambia il prezzo delle cose col loro valore”. E mentre i ragazzi si allontanavano ridacchiando, una brezza autunnale sollevava foglie morte sulla lastra tombale, cancellando per l’ennesima volta quelle cifre incise a caratteri cubitali.
Cifre che, nella loro arroganza numerica, non potevano comprare neppure un grammo di vero ricordo.