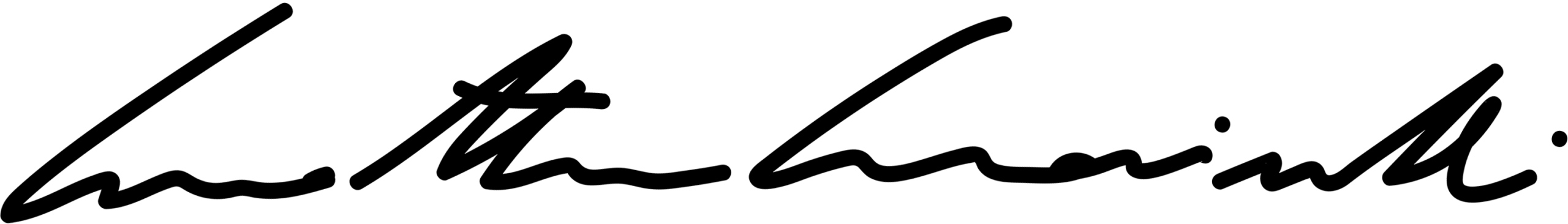Nel profondo e insondabile labirinto della psiche umana, ove il pensiero si smarrisce e il cuore trema d’un’inquietudine inesprimibile, si annida, come un ospite segreto, una stanza vuota, priva della più tenue luce e del più flebile barlume, ove risiede perpetuamente la sensazione d’una mancanza, d’un’assenza che, sebbene ci si circondi d’acquisizioni splendide e s’ascenda a vette di gloria inaudite, non cessa di risuonare con una eco spettrale. Non si tratta, ahimè, di una vacuità volgare e banale, ma d’una sete ontologica così profonda e lacerante da tramutare l’esistenza medesima in un palazzo incompiuto, con saloni sbarrati, scalinate sospese nel nulla e finestre murate come occhi ciechi. In tale abisso di desiderio, si è indotti a credere, con una credulità puerile e fatale, che la sorgente d’ogni bene risieda all’esterno, che il mondo sia una cassetta di Pandora sigillata e che la chiave, beffardamente sottratta da mani dispettose o da un capriccio degli astri, sia irrimediabilmente perduta.
E così ha inizio la funesta e languida danza della frustrazione, un lamento malinconico che ci spinge a volgere gli occhi al cielo, non con la nobiltà d’un osservatore, ma con la supplica d’un mendicante di stelle, mentre si maledice il fato iniquo, l’ingiustizia universale e l’insopportabile e tormentoso peso dell’attesa. Eppure, quale animo, tra la folla, possiede il coraggio titanico di scrutare il proprio intimo e di interrogarsi con onestà sulla propria effettiva dignità, confrontandola con la magnificenza di ciò che ardentemente agogna?
Nel vasto, incommensurabile teatro dell’esistenza, il desiderio medesimo, qualora sia sottoposto al disincantato, gelido e quasi chirurgico scrutinio d’un’osservazione spogliata d’ogni velo illusorio, si rivela nella sua vera natura, che non è già intrinsecamente nobile, bensì sovente impaziente, cieca e d’una puerilità desolante. Noi, con una brama che rasenta la follia, aneliamo a un amore d’indicibile profondità, eppure, nell’istante medesimo, la nostra fragile anima si dimostra incapace di tollerare il più tenue bisbiglio del silenzio che la solitudine reca seco. Con una tracotanza che sfida l’irragionevolezza, pretendiamo la prosperità, nondimeno trattiamo l’oro e le sue manifestazioni terrene come un nemico arcano, un’entità misteriosa la cui natura ci è irrevocabilmente preclusa. Agogniamo il riconoscimento come il naufrago agogna la riva, ma non siamo disposti a sopportare l’invisibilità, quella lunga, oscura e tormentosa notte che indefettibilmente precede l’alba di ogni maestria degna di tal nome. Attendiamo, quasi esigendoli con una boria insipiente e irriflessiva, miracoli che illuminino la nostra via, senza mai, invero, prepararci al fardello gravoso, all’inevitabile e tragico peso che ogni prodigio porta con sé. E come, dunque, potrebbe l’universo, in un atto di suprema e incomprensibile generosità, affidare la corona del potere a colui che non ha ancora dimostrato di saper reggere, con la dovuta grazia e solennità, il più umile e semplice dei cappelli?
Soffermiamoci, per un istante fugace, a contemplare la figura tragica d’un uomo il quale, consumato da un’ardente febbre d’ambizione, sogna d’essere il comandante d’un maestoso veliero, d’innalzare le vele al vento e solcare gli oceani. E nondimeno, la sua mente, obnubilata da un’insensata presunzione, non ha mai, neppure per un istante, imparato a decifrare l’inesorabile linguaggio delle costellazioni, a interpretare l’imperscrutabile umore dei venti o a comprendere l’eterno, muto e implacabile fluire delle correnti marine. Eppure, egli esige, giacché di una mera e sconsiderata pretesa si tratta, non di un diritto, che il vasto, indifferente e maestoso mare gli porga, quasi come un dono dovuto, l’agognato vascello. Egli non si interroga sulla propria preparazione, non si tormenta per la propria ignoranza, ma si affligge unicamente per il ritardo, l’inesplicabile ritardo dell’avvento di quella nave. Ebbene, se quell’imponente imbarcazione giungesse, essa non sarebbe la sua salvezza, non il faro che lo guiderebbe verso lidi sicuri, ma la sua rovina certa, il tragico strumento del suo fallimento. Sarebbe come porre una fiaccola ardente, fiammeggiante, nelle mani tremanti di un fanciullo: essa, invece di squarciare il velo delle tenebre e illuminare il cammino, non farebbe che portare distruzione, un’implacabile e rovinosa catastrofe.
Vi sono, pertanto, solo due vie dinnanzi al nostro spirito inquieto e bramoso: o innalzare il proprio impegno, con uno sforzo titanico e incessante, fino a eguagliare la vastità del proprio desiderio, o, al contrario, ridimensionare la portata delle proprie ambizioni fino a che non corrispondano alla misura del proprio sforzo attuale.
Il mondo, lungi dall’essere un’entità crudele, spietata o ingiusta, si erge, al contrario, come un giudice d’un’impeccabile, inesorabile coerenza. Per cogliere i frutti d’oro che la vita ci promette, è imperativo, prima di ogni altra cosa, trasformarsi nella persona stessa che possiede l’intrinseca capacità di afferrarli. Non esistono scorciatoie che possano resistere alla prova del tempo, né premi immeritati che non si mutino, ineluttabilmente, in un peso insopportabile, in una croce troppo greve da portare. La vita, in questo senso, agisce come un eccellente, silenzioso e immutabile arbitro: non ci concede ciò che chiediamo con le labbra, ma ciò che, con la sostanza del nostro essere, siamo in grado di sostenere. Questa verità, da un lato, illumina con una nuova e inattesa luce gli eventi avversi, poiché non ci sono mai affidate sfide che il nostro spirito non possa, in ultima analisi, affrontare e superare; dall’altro, svela una scomoda, amara verità: o si incrementa, con tenacia indomabile, il proprio sforzo, o si riduce la presunzione delle proprie attese. Se bramo un amore d’indicibile profondità, devo, innanzitutto, diventare un’anima capace di quella profondità. Se agogno una professione creativa e libera, è mio dovere acquisire la disciplina di ferro che quella libertà esige e incatena. Se anelo al riconoscimento, devo trovare in me il coraggio di espormi, di rendermi vulnerabile, di presentarmi al cospetto del giudizio altrui. In caso contrario, ciò che desidero non è un nobile sogno che onora lo spirito umano, ma un vano, puerile e inconsistente capriccio.
La stragrande maggioranza di ciò che la nostra anima percepisce come un’insopportabile, tragica mancanza non è, in verità, che una profonda e irrisolta disarmonia, una disperata asincronia fra l’impetuosa foga del nostro desiderio e l’attuale, imperfetto stato del nostro essere. È, per dirla con una metafora più chiara, come l’eco distante di una musica soave e celestiale, e il corpo che, in un’assurda immobilità, deve ancora imparare l’arte sublime di danzare a quel ritmo. La vita, lungi dal volerci punire ritardando in un gesto di maligna crudeltà i suoi doni più preziosi, ci invita, con un’infinita pazienza, a prepararci a dovere, a divenire degni di ciò che bramiamo. È, invero, come la terra umile e feconda che, pur anelando all’agognato seme, deve prima essere dissodata, pazientemente liberata dalla vile invadenza delle erbacce e irrigata con una sollecitudine che è tutt’altro che scortese: non per malizia, ma per un profondo, quasi sacrale amore per la fioritura che verrà.
Si consideri, in un moto di riflessione, colui che con ardore febbrile brama una relazione d’amore, eppure rimane, ineluttabilmente, schiavo delle proprie ferite interiori, di quelle cicatrici invisibili che il tempo non ha ancora sanato. Come potrebbe, dunque, un’anima così tormentata donare amore a un’altra, se non ha ancora appreso la divina arte di riceverlo per sé? E come potrebbe accogliere e contenere il fragile, complesso mondo di un’altra persona, se non ha ancora imparato a contenere se stesso nei momenti più tempestosi, quando la passione e il dolore minacciano di travolgere ogni cosa? E si pensi, parimenti, a colui che desidera una professione creativa, una vita fatta di bellezza e di espressione, ma che vive in un’esistenza scandita da orari irregolari, da abitudini inconsistenti e da una visione dell’esistenza annebbiata, confusa e offuscata. Non è forse evidente, persino a una mente ottenebrata, che un sogno così delicato, se si manifestasse in un tale stato di disordine, si dissolverebbe, senza lasciare traccia, come la sabbia sottile e impalpabile che scivola inesorabilmente tra le dita?
La vita, in questo senso, è meno un gioco insensato del fato e della fortuna, e più una scuola invisibile e severa, dove ogni desiderio che il cuore pronuncia è un esame e ogni assenza, ogni vuoto che percepiamo, è un paziente, silenzioso maestro che ci guida verso una saggezza più profonda. Troppi, in un’abissale miopia dello spirito, confondono il “non avere ancora” con un fallimento definitivo e irrevocabile; ma non tutto ciò che tarda è irrimediabilmente perduto, né destinato a scomparire nel nulla. Molte cose, al contrario, non giungono a noi proprio perché l’universo ci ama troppo per lasciarle rovinare, per permettere che si corrompano, tra le nostre mani ancora impreparate. La vita, in un gesto di suprema protezione, ci protegge, persino da ciò che bramiamo con il più ardente e disperato degli ardori.
Un amore che giunge troppo presto può, in un batter d’occhio, trasformarsi in una prigione di dipendenza. Una carriera che si manifesta prima di una vera maturità interiore può rivelarsi una dorata e luccicante prigione, le cui sbarre sono fatte di fama e ricchezza, ma che non lasciano intravedere alcuna via di fuga. Un successo non ancora metabolizzato dal profondo del nostro essere genera un’identità fragile, eretta su fondamenta sabbiose, destinate a crollare, ineluttabilmente, al primo soffio del vento. Allora, nel profondo e insondabile arco di questa attesa, di questo tempo sospeso tra la bramosia e il compimento, sorge spontanea e feconda una domanda, assai più ricca e fertile del vano lamento: “Come posso, con una dedizione paziente e meticolosa, preparare il terreno, dissodare l’anima, per accogliere ciò che il mio cuore, con ogni fibra del suo essere, ardentemente desidera?”
Poiché la verità è che non si può, invero, far entrare il nuovo nel tempio della propria esistenza senza prima aver creato uno spazio degno di esso.
Ogni vera trasformazione, ogni autentico passo verso un’evoluzione, esige una morte simbolica, dolorosa e sublime al contempo: la morte delle vecchie abitudini, di quelle catene invisibili che imprigionano lo spirito; la morte dei pensieri obsoleti, come foglie secche su un albero che si prepara a rifiorire; la morte di quelle versioni di noi stessi che, pur avendoci accompagnato nel passato, non ci appartengono più. Per abbracciare una nuova fase della vita, è necessario, con un atto di supremo coraggio, morire alla precedente. E questa morte, benché spesso solitaria, silenziosa e dolorosa, è irrevocabilmente e ineluttabilmente necessaria: ripulire il proprio spazio emotivo, come si farebbe con una stanza polverosa; mettere ordine nella propria dimora mentale, come si riorganizzerebbe una biblioteca disordinata; imparare a gestire il tempo, la parola, la promessa, ogni singolo frammento della propria esistenza. Tutto ciò costituisce l’architettura invisibile del destino. E così, nel tempo dell’assenza, in questa valle di vuoto che si estende dinnanzi a noi, abbiamo una scelta che definisce il nostro spirito: lamentarci per il vuoto che ci circonda, o coltivare con sollecitudine e pazienza il contenitore che, un giorno, sarà colmo di tutto ciò che abbiamo atteso.
La vera arte del vivere, oserei dire, non consiste nel forzare con violenza le porte del destino, ma nel diventare degni della chiave che, al momento opportuno, le aprirà. Significa prepararsi, con la disciplina di un monaco e la determinazione di un guerriero. Scegliere di crescere, come un albero che si slancia verso il cielo. Lasciar andare ciò che non siamo più, per accogliere con cuore aperto ciò che potremmo divenire. E in tutto ciò, riporre la propria fiducia, non in un fato cieco e capriccioso, ma in un ordine sottile e profondo che premia la coerenza tra il nostro intimo essere e ciò che, con la nostra invocazione, chiamiamo a noi.
Forse ciò che oggi ci manca non è affatto lontano. Forse ci osserva, celato dietro il velo del tempo, in attesa non che arrivi il momento giusto, ma che noi diventiamo il momento giusto.
E quando questo accadrà, non ci sembrerà più un miracolo sceso dal cielo, ma qualcosa che, nel profondo e antico del nostro essere, era sempre stato lì, in attesa di essere pienamente rivelato.